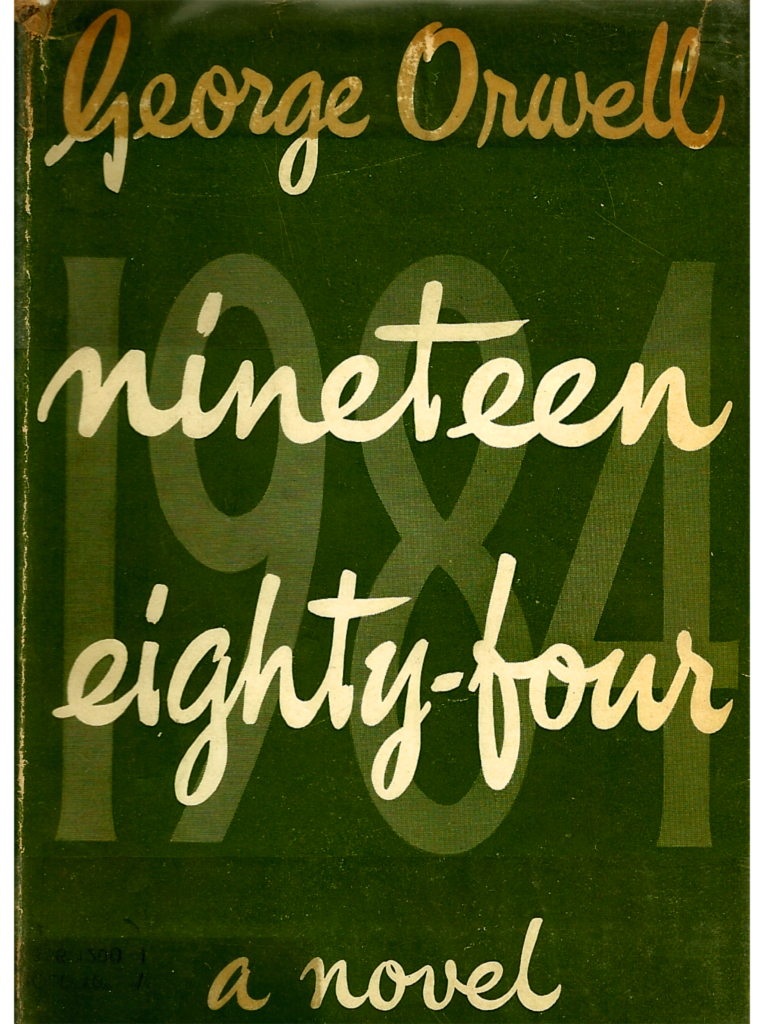"Non soddisfatto dei colpi che ha già dato alla Costituzione negli anni dei suoi governi, Berlusconi fa capire che o Letta gli consegnerà chiavi in mano l’”architettura” della Costituzione, oppure questo Governo non si farà.
"Non soddisfatto dei colpi che ha già dato alla Costituzione negli anni dei suoi governi, Berlusconi fa capire che o Letta gli consegnerà chiavi in mano l’”architettura” della Costituzione, oppure questo Governo non si farà.
Chiede di essere lui stesso a dirigere quella “Convenzione” che, collaborando col ministero delle Riforme Costituzionali (è la prima volta nella nostra storia che esiste un Ministero per le Riforme costituzionali) , ha l’obiettivo di scardinare la democrazia parlamentare per trasformarla in quel presidenzialismo che solo Quagliarello ha sostenuto nel lavoro dei saggi. I quali, nella relazione finale consegnata a Napolitano, hanno voluto chiarire che: “in modo prevalente (3 componenti a 1) il gruppo di lavoro ha ritenuto preferibile il regime parlamentare ritenendolo più coerente con il complessivo sistema costituzionale, capace di contrastare l’eccesso di personalizzazione della politica”.